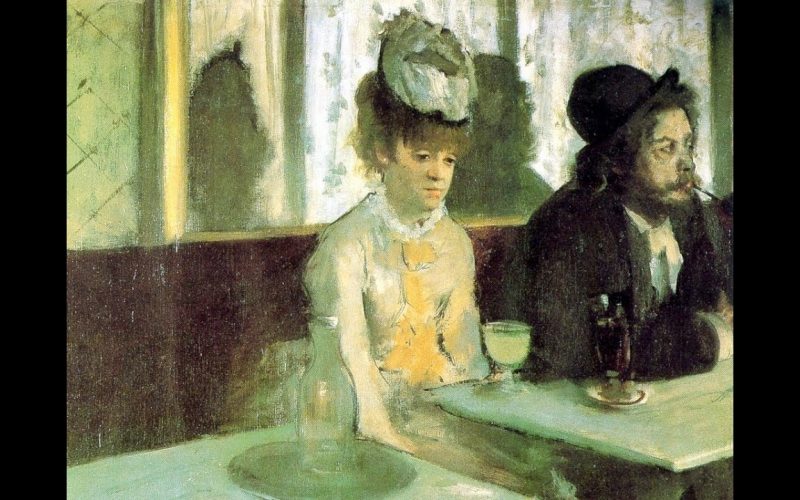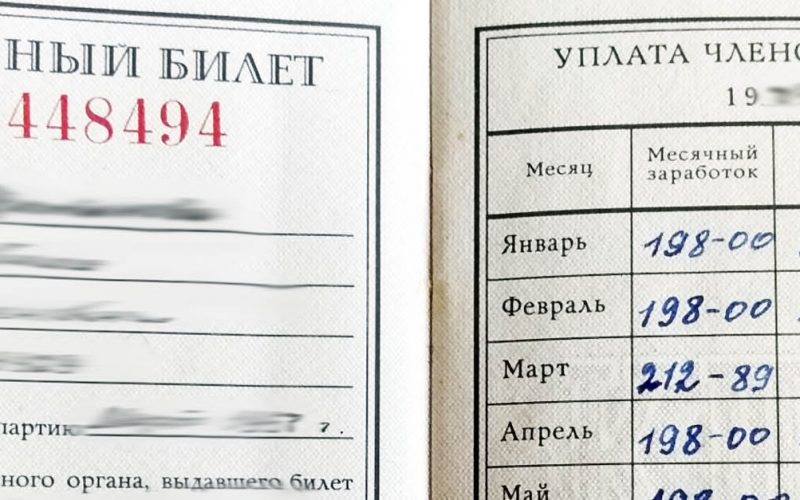14 Maggio 2022
Guardare il bene, per affrontare il male
Sono sempre più convinta che la vita è parecchio più complessa e più misericordiosa di quanto appaia nella rete. Facebook di giorno in giorno sbraita, piange che ormai tutta l’Europa odia quelli col passaporto russo; che deve odiare, e odierà per sempre la lingua e la cultura russe, e meritatamente, che piaccia o no.
Viceversa i miei amici polacchi, i loro amici e gli amici dei loro amici parlavano con grande simpatia di quelli che sono rimasti in Russia come di quelli che hanno dovuto andarsene, e con genuina ammirazione di quelli che, pur senza troppo farsi vedere, protestano contro la guerra («ci ricordiamo bene com’era da noi nel 1982, quando per una parola ti potevano arrestare, da voi adesso è molto peggio»); hanno chiesto se potevano essere d’aiuto, volevano sapere delle proteste russe («capiamo che la coda della propaganda putiniana raggiunge anche noi»), facevano tante domande, cercavano di capire.
La rete grida che d’ora in poi gli ucraini odieranno per sempre le persone che parlano russo, così dev’essere, e cambierà solo coi figli dei loro figli, se pure cambierà…

(P. Szefernaker, twitter)
Quanto a me, ho in mente l’autobus col quale sono tornata da Varsavia a Vilnius. Se escludiamo me stessa, due bielorussi di Minsk e una signora «della Vilnius russa» (come si è definita), ci viaggiavano solo persone che erano finite in Polonia non di propria volontà ma per scappare dalla guerra. Gente di Vinnica, Char’kov, Irpen’, Kiev, Uman’, Mariupol’.
La più incattivita sull’autobus era la famosa signora «della Vilnius russa», sibilava con aria provocatoria, sputava veleno, vomitava sentenze propagandistiche, e non riusciva proprio a mandar giù che gente che si vedeva per la prima volta chiacchierasse indifferentemente in russo o ucraino, così come veniva, e che nessuno maledicesse nessun altro, anzi, che «questi Bandera» fossero compìti come allievi di un college britannico.
Parlavamo tra noi pacificamente, ci raccontavamo dei nostri paesi («Io sono di Uman’ – ha detto con orgoglio la mia vicina – Probabilmente lei non sa che da noi abbiamo gli hassidim e il loro rebbe; Uman’ è il centro del hassidismo in Europa», ed era contenta quando le ho detto che so di Uman’ e del rebbe), ridevamo, ci raccontavamo storie… Erano storie di vario genere, alcune sarebbero dolorose da ripetere qui ma in quel momento, sulla strada da Varsavia a Vilnius, lo storytelling, com’è giusto che sia, aiutava a ricostituire il cosmo distrutto e ad allontanare la disperazione.
Alle fermate acchiappavamo insieme i bambini – guidati da un «capo pellerossa» di sei anni di Šepetovka – che si intrufolavano esclusivamente dove non dovevano, e ci divertivamo perché quei bambini pestilenziali urlavano così forte che gli adulti non riuscivano a sentirsi. «Voglio tornare a casa…», ha singhiozzato Olja di Mariupol’, guardando la casa di fronte alla fermata di Sejny. L’hanno abbracciata, tranquillizzata con la promessa che sicuramente tutto bude dobre (andrà bene). Hanno consolato anche le ragazze importunate dalla signora «della Vilnius russa», che domandava insolente: «Scusate, ma anche voi siete state violentate? Vi hanno violentate? E allora perché venite qui a farvi mantenere da noi?»; e poi spiegava loro che «le stavano salvando dai nazisti». La signora era volgare e impenitente, come il primo canale della tivù russa, che è vietato in Lituania ma che si può vedere in internet.
Non aveva senso mettersi a discutere con lei; fra noi l’avevamo soprannominata Crudelia De Mon, e ragionavamo che dev’essere ben triste vivere in un mondo che ti è odioso. A me chiedevano, senza rancore ma piuttosto con ansia, della Russia, di Naval’nyj («è vero che il vostro governo lo vuole distruggere, come noi?»), perché all’inizio della guerra non sono scesi in piazza milioni, cercavano onestamente di capire.
Per tutta la strada abbiamo condiviso non solo le storie ma i beni primari di un viaggio in autobus. «Gente, ho un caricatore portatile, a chi serve?». Si condivideva volentieri, con la leggerezza tipica delle persone libere. Non era semplice generosità ma una specie di rassicurazione: se si può dare qualcosa, vuol dire che la vita è viva, che tutto bude dobre, andrà bene.
Lo so, lo so che può essere molto diverso, che spesso è diverso e lo sarà ancora a lungo. Ma mi sembra assolutamente importante raccontare della parte «luminosa».
Non perché sono un’incorreggibile anima bella, ma perché se incateno la mente e lo sguardo al solo male finisco involontariamente per moltiplicarlo, per assecondarlo anche solo col pensiero.
Accettare di riconoscere «l’altro lato» – senza mai dimenticare la sciagura – accettare di vederlo, mantenere la capacità di vedere il bene, è anche questa una forma di resistenza. L’azione solidale non richiede soltanto di avere una rabbia comune ma anche di sapere che la vita è ben più complessa, misericordiosa e multicolore di quel che vede la rete.