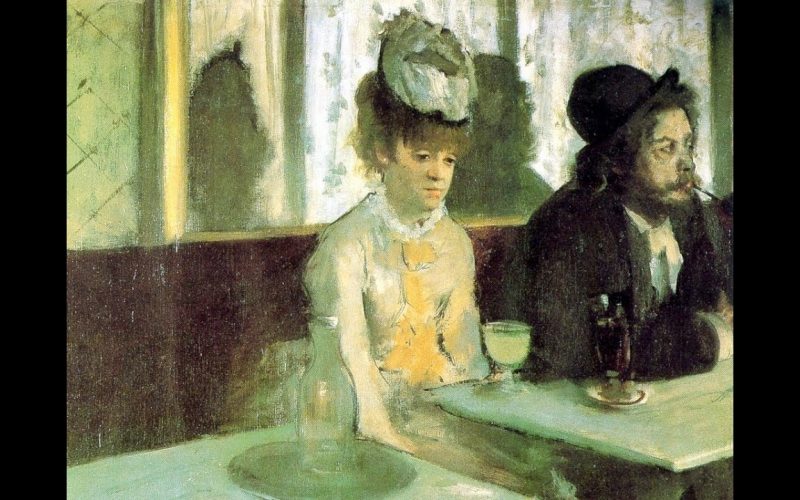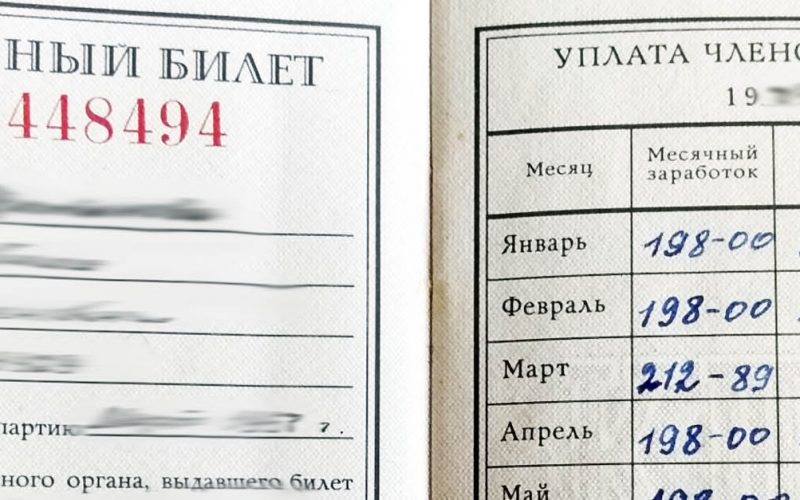11 Aprile 2019
È sciocco sperare? A cinque anni dall’occupazione della Crimea
Ho letto quel che ha scritto un mio amico e collega, Aleksej Kamenskich, sulla pericolosità della speranza «davanti a quel che succede in casa nostra» e, forse per il fatto che so fin troppo bene cosa sia «perdere la speranza», e fors’anche per la mia irriducibile tendenza a discutere con gli amici, vorrei rispondergli.
Quel giorno ignominioso di marzo avevo progettato di andare a teatro e poi a bere qualcosa con le amiche. Strada facendo, decisi di fare un salto da un’amica che abita vicino al metro «Tret’jakovskaja», e giù nel metro vidi una folla da quadro di Bosch. Delle signore sovreccitate, con le bandierine russe che spuntavano dalle borsette, un ubriacone all’ultimo stadio, dalla sporcizia cronica e la giacca sbottonata che, reggendosi a stento sui gradini della scala mobile, berciava: «C… siamo russi!», delle ragazze che ridacchiavano nervosamente, gente animata con l’espressione da circostanza tipica dei funzionari… Avendo scorto una persona dall’aria più sobria e colta, gli chiesi cosa si stesse festeggiando. «Ma come, non lo sa?! – si indignò quello: – Ora la Crimea è nostra!».
Dalla mia amica non riuscii a imbastire una conversazione e quella sera a teatro non ci andai, ma vagai sulla Taganka pensando soltanto come poter vivere oltre…
Quel giorno iniziò un periodo di dolore, vergogna, paura, speranza e poi ancora dolore e vergogna… Mi spiegarono più e più volte che tutte le persone dabbene dovevano svignarsela da questa fogna. Io ero pronta ad accettarlo, ma poi andavo sul prospekt Sacharov per una marcia o un meeting, mi guardavo attorno e capivo che no, non proprio tutti… Se ne era andato chi era stato obbligato, chi lo aveva ritenuto necessario, ma il fatto di partire non può essere usato come criterio di onestà e neanche come oggetto di un giudizio etico. E poi, tra i «rimasti» ho trovato e trovo tante persone oneste, nei luoghi più impensati, mentre là dove i cosiddetti uomini dabbene sono andati a finire, beh… non dico cosa ho trovato.
E poi abbiamo iniziato i corsi per studenti, con te Aleša, e con Oksana, erano un tentativo di contrapporre alla lingua dell’odio un’altra lingua, talvolta debole, anche criticabile ma intenzionalmente indirizzata alla narrazione del dolore, della vergogna, dei traumi storici e delle possibilità di guarigione. In queste conversazioni, nella possibilità stessa d’incontrarsi, di ascoltarsi reciprocamente, di rivolgersi domande molto scomode, magari di alzare la voce e poi abbracciarsi, chiedersi scusa e di nuovo mettersi a pensare insieme, per me c’è più speranza che nelle più ottimistiche delle prospettive politiche.
Più mi gridano forte e con ira che tutte le persone dabbene devono squagliarsela da Mordor, più io mi convinco – forse per il mio granitico anticonformismo – che il cosiddetto Mordor è il mio paese. E proprio perché è mio soffro e mi vergogno tanto. Quello che è degli altri si può condannare, prenderne le distanze ma non se ne prova vergogna. Non si ha vergogna degli altri ma di sé, della propria incapacità di fermare, di spiegare, di condividere in modo da farsi ascoltare. Sì, il mio paese è molto malato. A confronto di quelli sani, garbati, che profumano d’acqua di colonia, è un barbone puzzolente di cui non ci si può vantare, di cui però si può rispondere. Là dove posso. Così come posso cerco di non fare del male, di non unirmi al coro delle menzogne. Posso custodire, pensare, condividere, chiedere perdono quando il malato si comporta per l’ennesima volta in modo asociale; posso cercare, come riesco, di fermare, aggiustare le conseguenze delle sue azioni… Posso riflettere, interrogare, senza ricorrere a risposte già fatte. Sì, e poi posso rallegrarmi del fatto che esiste qualcuno e qualcosa con cui essere solidali, con cui creare una comunità non «contro» ma così, perché non è bene che le persone stiano da sole. Il «mio paese» per me non è un sentimento, non è la terra e non è l’orgoglio, è innanzitutto una responsabilità, che certe volte è dura da portare.
Sì, potrebbe succedere che l’opera a me casualmente affidata mi porti lontano, però me ne andrei non da «questo» paese ma dal mio paese, e continuerei a vergognarmene, addolorarmene, rallegrarmene perché è «il mio».
Quanto alla speranza… Aleša, ricordi che durante l’ultima scuola estiva, dopo abbondanti libagioni di vino georgiano, abbiamo cantato tutti insieme canzoni ucraine, bielorusse, tedesche, Okudžava e Tumbalalaika in yiddish? E poi, che urla abbiamo lanciato quando gli studenti russi, ucraini, bielorussi e tedeschi, tutti insieme, non hanno lasciato pietra su pietra di quel primo giorno? E l’anno prima c’era stata la scuola in Lituania, e dopo l’intervento di Vanja sui deportati lituani nella regione di Perm’ la padrona della fattoria, Lajma, per la prima volta dopo molti anni raccontò come avevano deportato la sua famiglia… Adesso è tempo di preparare una nuova scuola e in tutto questo, in questi «piccoli dettagli» per me, che sono un’oscurantista, consiste il fondamento certo della speranza. Poi là vedremo.
Io direi che la speranza è occhiuta e temeraria, mentre la disperazione è cieca e pericolosa. Recentemente ho capito chiaramente che la menzogna e l’assurdo possono fare la sarabanda finché vogliono, possono affermare di avere pieno diritto, possono atteggiarsi a sentimenti elevati, ad unica verità in questo «mondo di puttane», ma ciò nonostante non avranno mai l’ultima parola… Quello che noi cerchiamo di fare sono piccole forme di resistenza all’entropia. Ed è vero che l’entropia arretra…