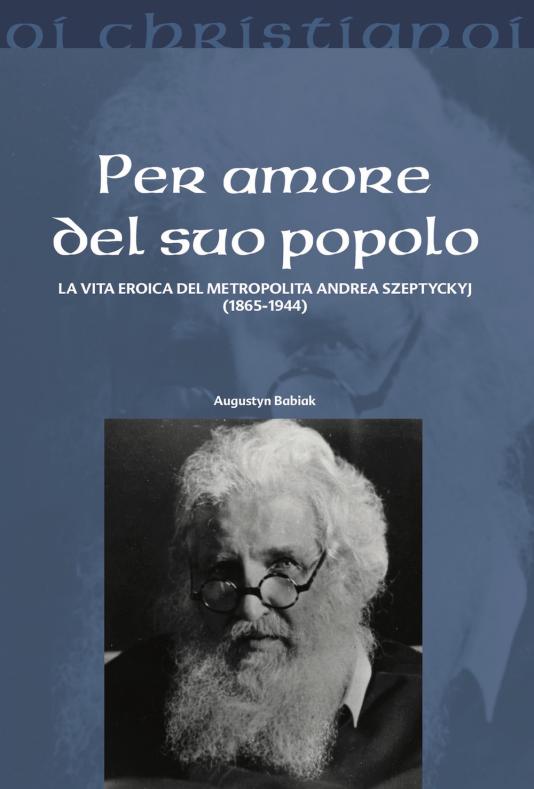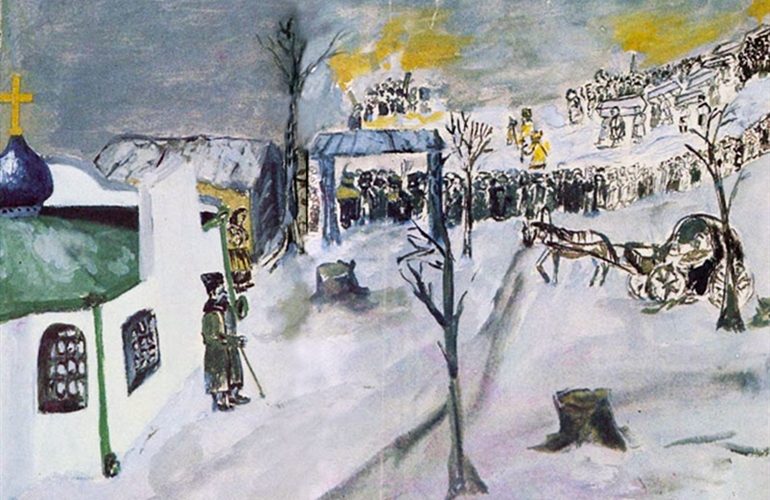- HOME /
- ARTICOLI /
- 2023 /
- Recensioni /
- Il patriottismo cristiano di Szeptyckyj
23 Settembre 2023
Il patriottismo cristiano di Szeptyckyj
La ricostruzione fedele della vita del metropolita dei greco-cattolici ucraini, mette in luce un’epoca non meno drammatica della nostra, e la sua scelta per Cristo. Senza tentennamenti.
Il libro è dedicato alla figura di Andrea Szeptyckyj (1865-1944), personalità ancora relativamente poco conosciuta nonostante il ruolo di testimone di Cristo che ha portato sin dal 1958 ad aprire la sua causa di beatificazione e nel 2015 alla promulgazione del decreto sulle sue virtù eroiche. Molto opportuna in tal senso è dunque la preoccupazione che attraversa tutto il lavoro di Augustyn Babiak (sacerdote cattolico di rito bizantino, nato in Polonia e oggi, dopo aver conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Lione, cappellano della comunità ucraina del Trentino-Alto Adige): ricostruendone la vita, l’autore si preoccupa in primo luogo di mostrare come Szeptyckyj fu sempre e soprattutto un testimone di Cristo e, tra le altre cose, si preoccupa di mostrarlo con grande precisione proprio in quello che fu uno degli aspetti più contestati della sua storia personale, la sua posizione politica che, a dispetto di tante riduzioni e semplici calunnie, si configura invece «come un delicato e sempre cercato equilibrio tra patriottismo e universalismo cristiano»: attaccato dagli uni come anti-polacco strumentalizzato da altri come anti-ucraino, in realtà fu semplicemente un servitore della cattolicità della Chiesa «inviata in missione da Cristo alla totalità del genere umano».
Nato nel 1865 in una famiglia di antica nobiltà galiziana le cui origini si perdono nel XIV secolo (in seguito polonizzatasi e convertita al cattolicesimo nel XIX secolo), Szeptyckyj si trovò in effetti a vivere tra impero russo, impero austro-ungarico, Ucraina, Polonia, Lituania, in una situazione in cui le lotte politiche e le tragedie militari ebbero uno spazio enorme, che ben giustifica l’immagine che Timothy Snyder ha recentemente utilizzato come titolo per un suo famoso libro: Terre di sangue.
In questa tragedia Szeptyckyj si trovò con un ruolo sin dall’inizio centrale: monaco dell’Ordine basiliano di rito orientale di San Giosafat dal 1888, ordinato sacerdote nel 1892, consacrato vescovo nel 1899, dal 1900 divenne metropolita di tutta la Chiesa greco-cattolica ucraina, con un incarico che avrebbe ricoperto ininterrottamente fino alla morte nel 1944.
Fu dunque a capo di questa Chiesa in un periodo che conobbe la Prima guerra mondiale, la rivoluzione del 1917, la guerra sovietico-polacca del 1920-1921 e la Seconda guerra mondiale e, proprio nel cuore di queste lotte, seppe sempre affermare innanzitutto la centralità di Cristo e la sua capacità unica di restituire l’umano all’umano.
Lo fece nel 1908 quando, nel cuore delle lotte politiche per l’indipendenza dell’Ucraina, dopo l’omicidio del governatore polacco della Galizia per mano di un patriota ucraino, si rivolse al proprio popolo con un’allocuzione nella quale pronunciò queste parole:
«Non si serva la nazione con i crimini! Un delitto commesso in nome della patria è un crimine non solo contro Dio, ma anche contro la società umana e quindi contro la patria».
E la stessa posizione mantenne poi anche in seguito, quando la sua gente dovette far fronte prima al regime sovietico e poi a quello nazista. Nel primo caso, in occasione della grande carestia dell’inizio degli anni Trenta (il Holodomor), ci fu la denuncia e la condanna senza mezzi termini del comunismo sovietico come un «sistema cannibalesco di capitalismo di Stato», «nemico di Dio, del cristianesimo e della natura umana»: «L’Ucraina sta lottando con la morte. La gente sta morendo di fame. Il capitalismo di Stato che poggia sull’ingiustizia, sull’inganno e sull’ateismo, ha portato il paese, una volta così ricco, alla completa rovina», scrisse il metropolita.
Non meno dura e inequivocabile fu la condanna del nazismo, come venne riconosciuto dalla comunità ebraica e come risulta in maniera inequivocabile dai documenti pastorali e dalle lettere che lo stesso Szeptyckyj scrisse al cardinale Tisserant allora segretario della Congregazione per le Chiese orientali e poi allo stesso papa Pio XII nel 1942.
In particolare, in una prima lettera pastorale dal titolo Sull’omicidio (del 9 ottobre 1941), informato dei primi pogrom scatenati contro gli ebrei, il metropolita, quasi richiamando l’allocuzione del 1908, scrive: «La nazione che non ha imparato a rispettare la vita umana è una nazione di selvaggi, non degna di stare fra le nazioni cristiane nel mondo».
In seguito, in una lettera al papa del 28 marzo 1942, denunciando e correggendo chiaramente anche la simpatia con la quale una parte della società civile poteva aver accolto all’inizio le truppe tedesche, viste come liberatrici dal comunismo, Szeptyckyj scrive dei nazisti: «Hanno chiamato gli ucraini “amici” e anche “alleati”, ma, già dopo qualche settimana, noi abbiamo capito che queste erano soltanto parole. Ci hanno ingannato ignobilmente e noi potremmo produrre centinaia di casi in cui abbiamo sperimentato un potere e un regime implacabili. (…) Temiamo che il peggio sia ancora davanti a noi perché questo regime è il regime del “Terrore”».
E il giudizio viene poi confermato e aggravato in un’altra lettera del 29-31 agosto dello stesso anno, là dove il metropolita scrive: «Oggi tutto il paese è concorde nell’affermare che il regime tedesco è forse peggiore del regime bolscevico, in quanto a cattiverie e atrocità, un regime quasi diabolico. (…) Gli ebrei sono le prime vittime e il numero di ebrei assassinati nel nostro piccolo paese ha certamente superato i duecentomila. (…) Ho protestato con Lettere pastorali, naturalmente confiscate, nelle quali denunciavo gli omicidi, lettere discusse e meditate, in quattro o cinque riprese, davanti al clero radunato. Come ordinario ho dichiarato l’omicidio causa di scomunica. (…) Tutti noi prevediamo che il regime del terrore andrà aumentando (…). I boia, infatti, abituati a massacrare ebrei e migliaia di persone innocenti, sono abituati a versare sangue e hanno sete di sangue».
«Si tratta di un regime di pazzi furiosi», avrebbe scritto ancora in una lettera del 28 dicembre 1942 al cardinale Tisserant, accompagnando questa ennesima denuncia alle disposizioni «perché i monasteri studiti della sua eparchia concedessero rifugio agli ebrei».
A spiegare le ragioni di queste prese di posizione non basta la particolare acutezza di giudizio politico, che pure il metropolita ebbe, come attesta la sua costante preoccupazione di creare per il bene di tutto il popolo un’atmosfera di «rispetto, carità, collaborazione e riconciliazione» reciproca. Come ben sottolinea l’autore, tutto ciò si radica in altro: l’amore a Cristo e alla sua opera di salvatore e redentore dell’uomo.
Del resto è quello che notò suo padre, quando, all’alba del suo ingresso nell’ordine basiliano, osservò che «a chi è innamorato di Cristo non basta il mondo intero», così che la riconciliazione tra i diversi popoli, le diverse tradizioni e le diverse culture non è né un dettaglio superfluo né il frutto di chissà quale innovazione o sensibilità particolare ma, come avrebbe detto molto più tardi Paolo VI, il riconoscimento della struttura dell’uomo e del mondo cristiano: «La carità ci rende più consapevoli della profondità della nostra unità, mentre allo stesso tempo rende più dolorosa l’attuale impossibilità di vederla fiorire nella concelebrazione, e ci incoraggia a fare tutto il possibile per affrettare la venuta di questo giorno del Signore. (…) La carità è l’ambiente vitale necessario perché la fede fiorisca, e la comunione nella fede è la condizione per la piena manifestazione della carità espressa nella concelebrazione», dove proprio nella carità e nello spirito del metropolita (anticipatamente scevro da proselitismo, sincretismo, ristrettezza di spirito e, tanto più, sciovinismo), scompariva ogni spirito di conquista e cominciava a scoprirsi una nuova mentalità fatta soprattutto di un’accoglienza del diverso, a sua volta frutto anche di una migliore conoscenza reciproca dei due mondi nei quali il metropolita viveva.
Non casualmente già nel 1907, nella lettera pastorale Arriveranno i tempi, il metropolita aveva detto esplicitamente che proprio il suo popolo per la sua storia poteva svolgere un ruolo decisivo nel lavoro ecumenico:
«Uniti nella fede con l’Occidente, uniti nel rito con l’Oriente, più che alcun altro possiamo nel futuro lavorare per questo progetto, per ristabilire la piena unità ecclesiale».
E questa coscienza appare tanto più importante oggi, quando l’esempio del metropolita Andrea Szeptyckyj potrebbe davvero essere l’indicazione di una via per la riconciliazione di popoli e mondi che, un tempo sconosciuti e ora nemici, hanno già avuto padri capaci di guidarli sulla via dell’unità, indicandone in Cristo la sua ragione ultima.
Adriano Dell’Asta
È docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI