- HOME /
- ARTICOLI /
- 2019 /
- Recensioni /
- Leningrado memorie di un assedio
13 Dicembre 2019
Leningrado memorie di un assedio
Il libro sull’assedio di Leningrado scritto da Lidija Ginzburg e tradotto da Memorial Italia si presenta abbastanza anomalo: l’autrice non è apologetica né polemica, è un’osservatrice distaccata che illustra come la fame, il freddo e il rischio costante di morte fungono da «reagenti» che cambiano l’uomo, concentrandolo sullo sforzo della sopravvivenza.
Come libro di memorie quello scritto da Lidija Ginzburg (1902-1990) si presenta abbastanza anomalo. Critico letterario, studiosa di letteratura e scrittrice, Lidija Ginzburg era un’ebrea di Odessa trapiantata a Leningrado, che a partire dal 1925 sino alla morte ha tenuto dei diari in cui annotava tutti i colloqui interessanti e i fatti che accadevano; è su questo materiale che ha poi costruito i suoi libri, come questo sull’assedio. Bisogna ringraziare Memorial Italia che ha pensato di tradurre quest’opera per la collana «Narrare la memoria, le storie dimenticate dell’Europa dell’Est».
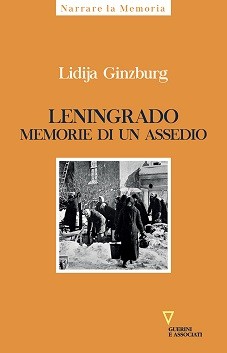 Di solito, quando si affronta la tragedia dei 900 giorni di Leningrado assediata dalle truppe tedesche nel 1941-44, i tipi di narrazione sono generalmente due: la narrazione eroico-patriottica, che descrive la fame, il terrore e la morte di milioni di leningradesi in toni epici soprattutto per esaltare l’eccezionale resistenza e forza d’animo del cittadino sovietico, e al tempo stesso stigmatizzare il male assoluto, rappresentato dagli assalitori «fascisti». Oppure c’è la narrazione antitotalitaria, che tra gli orrori dell’assedio vuole sottolineare la deliberata e assurda violenza del regime sovietico che anche in quella situazione continuava a colpire spietatamente i suoi. Insomma il tema offre spunti a tinte forti e di colorazione politica, in un senso o nell’altro.
Di solito, quando si affronta la tragedia dei 900 giorni di Leningrado assediata dalle truppe tedesche nel 1941-44, i tipi di narrazione sono generalmente due: la narrazione eroico-patriottica, che descrive la fame, il terrore e la morte di milioni di leningradesi in toni epici soprattutto per esaltare l’eccezionale resistenza e forza d’animo del cittadino sovietico, e al tempo stesso stigmatizzare il male assoluto, rappresentato dagli assalitori «fascisti». Oppure c’è la narrazione antitotalitaria, che tra gli orrori dell’assedio vuole sottolineare la deliberata e assurda violenza del regime sovietico che anche in quella situazione continuava a colpire spietatamente i suoi. Insomma il tema offre spunti a tinte forti e di colorazione politica, in un senso o nell’altro.
Ma non troviamo niente di tutto questo nella Ginzburg: a lei non interessa condannare l’infamia tedesca né l’infamia sovietica – due realtà che pure ha ben presenti (sua madre è morta di fame durante l’assedio) – perché è tutta tesa a osservare l’uomo, «l’uomo dell’assedio» come recita, appunto, il titolo originale. Si pone quasi come una scienziata della psiche e dell’animo umano, che scruta con la lente di ingrandimento le reazioni e le segrete concatenazioni tra realtà, pensieri e atteggiamenti; gli eventi estremi dell’assedio strappano le vecchie maschere, ma la gente ne cerca sempre di nuove per non sentirsi nuda. Nel suo studio Lidija Ginzburg non è apologetica né polemica, non intende dimostrare nulla, è soprattutto un’osservatrice distaccata, talvolta addirittura fredda: non c’è pathos nel suo racconto, anche se ha sofferto in prima persona tutto ciò che descrive.
Nel suo diario la Ginzburg illustra analiticamente come la fame, il freddo e il rischio costante di morte fungono da «reagenti» che cambiano l’uomo, concentrandolo sullo sforzo della sopravvivenza. Una sopravvivenza che è fisica ma anche mentale, e nell’ambiente intellettuale di cui la Ginzburg fa parte (è redattrice alla Radio cittadina) questo aspetto ha una certa importanza. Quando si arriva al limite estremo dell’inedia ciò che predomina è l’ossessione del cibo, oggetto di conversazioni maniacali, ma fra gli intellettuali anche questa ossessione si ammanta di finzioni: «La quantità di sofferenza aveva modificato la qualità della sensibilità… La fame vera, come è risaputo, non è come il desiderio di mangiare. Essa ha le sue maschere. Si manifesta con la faccia della miseria, dell’indifferenza, di un insano bisogno di crudeltà. Era simile a una malattia cronica, e come in qualsiasi malattia, la sfera psicologica aveva un ruolo importante» (p. 72).
Per difendersi dal caos e dall’annichilamento nascono così i riti e le strategie quotidiane che servono a preservare la mente e l’organismo dall’esaurimento ultimo: andare a prendere l’acqua, vuotare gli escrementi, decidere se mangiare la razione di pane tutta d’un colpo, nella speranza di sentire un minimo di sazietà ma poi restare digiuni per il resto del giorno, o suddividerla in tre pasti che non daranno soddisfazione alcuna. «L’uomo – osserva la Ginzburg, – vive su diversi piani, concepisce profondi valori ma può contemporaneamente ricavare gioia da piccole soddisfazioni» (p. 95).
Se questi aspetti emergono in tempi di fame e di morte, ve ne sono altri registrati dalla Ginzburg che valgono altresì in tempi normali, nelle sue osservazioni ritroviamo spesso degli affondo universali in cui ci possiamo riconoscere anche noi lettori del XXI secolo. Il tema del bene e del male è uno di questi: nelle sue osservazioni la Ginzburg mette a nudo sia l’illusione dell’eroismo catartico che l’utopia sociale del comunismo.
«Sotto il fuoco dell’artiglieria, i meccanismi del male sociale continuavano a essere gli stessi normalmente, così come l’eroismo e la forza d’animo… Il pensiero utopistico non vuole riconoscere che il male sociale è inestirpabile e che può assumere varie forme… La questione di vitale importanza è come sfuggire all’egoismo, facendo a meno della religione. Quale cittadinanza, quale amore, quale nobile fatica permetterà di evitare il supplizio infernale dell’egoismo?» (p. 158-159).
E più avanti, dopo aver osservato che la condizione dello schiavo, defraudato di tutto è lo stato più egoistico di tutti, commenta:
«L’uomo immanente, alienato dall’assoluto e dai valori universali, è una categoria socialmente tipica, presente con diverse tipologie in tutte le forme di società» (p. 162).
L’uomo immanente, socialista o borghese che sia, rivela gli identici impulsi e le identiche vanità, così, ad esempio, nella comunicazione interpersonale la Ginzburg individua come elemento principale l’affermazione di sé: «L’autoaffermazione, dissimulata attraverso quanto è obiettivamente interessante, assume la forma di un’informazione o un valore estetico. …In un modo o nell’altro, l’autoaffermazione è l’essenza psicologica indistruttibile della conversazione» (p. 58); «Da una realtà così peculiare come quella dell’assedio emergono tutti i meccanismi secolari che hanno governato l’arte della conversazione e che sulla spinta della vanità e dell’autoaffermazione hanno prodotto grandi capolavori da La Rochefoucauld a Tolstoj» (p. 122).
La prosa della Ginzburg, come il suo approccio al tema dell’assedio, è originale, raffinata, talvolta difficile, sempre penetrante. Abbiamo di fronte un’autrice non comune, che stranamente non ha mai raggiunto vasta notorietà in patria né all’estero, forse perché troppo anomala rispetto alla cultura sovietica, e poco «impegnata» rispetto a quella del dissenso.
Tuttavia queste pagine, che analizzano la vita impossibile di tanti uomini e donne travolti dalla grande storia, considerate globalmente appaiono un tentativo di rispondere al nichilismo che assaliva nell’assedio e che assale anche noi oggi: ancorarsi alla realtà, fisica e spirituale, aiuta – dice la Ginzburg – a non scivolare nel caos dell’indifferenza. Allora c’era chi resisteva «radendosi la barba o leggendo dei libri scientifici» (p. 126): «N. prima di uscire si occupa degli ultimi ritocchi per rendersi presentabile. Al posto della sudicia camicia del pigiama… indossa una vera giacca. Si annoda la cravatta. La cravatta svetta sul caos circostante».
Lidija Ginzburg
Leningrado memorie di un assedio
Guerini e Associati, Milano 2019, pp. 187, € 16,00
Marta Dell'Asta
Marta Carletti Dell’Asta, è ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si è specializzata sulle tematiche del dissenso e della politica religiosa dello Stato sovietico. Pubblicista dal 1985, è direttore responsabile della rivista «La Nuova Europa».
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI


